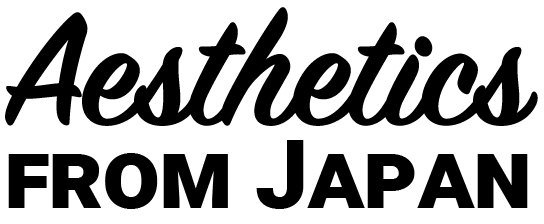Semplice è chic, la moda nel periodo Edo
Subito dopo la riunificazione del Paese nel diciassettesimo secolo, il bakufu avviò una severissima campagna politica per ridefinire i ruoli sociali della popolazione e assicurarsene il controllo totale. Il nuovo sistema gerarchico prese il nome di Shinōkōshō士農工商e prevedeva la suddivisione della società giapponese in quattro macro caste: i bushi武 i contadini, gli artigiani e i mercanti. Questi ultimi occupavano l’ultimo posto del sistema e venivano spesso considerati come persone di malaffare. Al di sopra della suddivisione vi erano invece lo Shōgun, l’imperatore e la sua famiglia e i kuge 公家. Le persone il cui lavoro implicava il contatto con il sangue, i crimimali e i mendicanti appartenevano a delle speciali categorie chiamate eta穢多e hinin非人 ed erano viste dei veri e propri fuori casta. Per poter ulteriormente rafforzare tali suddivisioni, lo shōgunato Tokugawa emanò un severissimo codice di leggi suntuarie per codificare l’abbigliamento e l’aspetto estetico dell’intera popolazione. Dettagli quali fogge, colori e pettinature erano perfettamente stabilite fin nel più minimo dettaglio per ogni ceto e le pene a cui si andava incontro qualora le leggi venissero infrante erano tutt’altro che leggere. Un sontuoso capo in seta, per esempio, divenne quindi un’esclusiva per le classi più alte, mentre i ceti più umili dovettero accontentarsi di indossare unicamente abiti realizzati con materiali più modesti quali canapa o cotone. La stessa distinzione riguardò i colori: le tonalità più accese e brillanti potevano essere indossati soltanto dai nobili e dalle famiglie più abbienti della casta guerriera; i blu, i grigi e i marroni, invece, diventarono i colori ufficiali della classe media.
Le nuove leggi suntuarie dimostrarono quanto l’establishment Tokugawa vedesse moda come elemento cruciale per il controllo della popolazione: controllare abiti, pettinature e trucco era effettivamente un ottimo metodo per gestire l’identità stessa di una persona. Dal momento che la moda era considerata anche un marcatore sociale, nei primissimi anni dell’epoca Edo furono i bushi e i nobili a decidere cosa dovesse essere più in voga: il loro guardaroba seguiva principalmente i dettami delle epoche Azuchi-Momoyama (1573-1603) e Muromachi (1336-1573) e prevedeva un ampio uso dei rossi, dei viola e dell’oro per entrambi i generi.

Con il trascorrere degli anni tuttavia, un nuovo tipo di bellezza si stava gradualmente diffondendo fra la borghesia urbana. Per poter sottostare al severo sistema suntuario, infattti, gli abitanti di città come Edo e Ōsaka iniziarono a cercare l’eleganza nella delicatezza e nella semplicità, dando vita a una complessa filosofia conosciuta come iki いき. A differenza dell’ostentata opulenza delle classi alte, la sensibilità iki trovava raffinatezza nei blu e nei grigi piuttosto che nei rossi e negli ori, e nella modestia piuttosto che nell’abbondanza. Le cortigiane dei quartieri di piacere usavano spesso la parola “iki” come aggettivo per riferirsi a un’eleganza erotica ma comunque sottomessa. Iki rifletteva un forte desiderio di essere sensuale in maniera educata e aggraziata. Essere “iki” quindi non significava indossare semplicemente un indumento in tinta pastello, ma mostrare determinati atteggiamenti e comportamenti considerati fondamentali quanto un abito per raggiungere uno stile ben definito. Gli attori del teatro Kabuki, come gli onnagata女形, e le geisha erano considerati l’apoteosi dello stile iki, sia per il loro aspetto che per i loro modi di fare. Ciò nonostante, non tutti gli abitanti dell’ukiyo potevano incarnare il gusto iki. L’antropologa Liza Dalby scrisse che, in epoca Edo, una geisha aveva più possibilità di essere considerata iki rispetto a una oiran 花魁, una cortigiana di alto livello, o a una yūjo 遊女. I loro abiti sgargianti, gli enormi obi annodati al contrario e la loro parlata prolissa erano in realtà l’antitesi di questa filosofia. Neanche una brava moglie dei ceti più umili poteva essere definita iki, dato che il suo stile semplice e la mancanza di trucco venivano visti come scialbi e insignificanti. Contrariamente, una geisha che indossava un kosode 小袖 con delicati motivi e un obi sobriamente annodato con un fiocco nella schiena rappresentava uno squisito esempio di quella che doveva essere l’estetica iki. Inoltre, elementi come un erotismo appena accennato e un tocco di originalità, contribuivano indubbiamente a raggiungere il picco dell’immagine iki. Una geisha iki doveva essere elegante, ma mai eccessiva, audace ma mai eccentrica.

I protagonisti del Mondo Fluttuante diventarono il nuovo modello estetico da seguire, surclassando i membri delle classi alte; ciò però non significava che un bushi o una oiran non potessero essere etichettati come iki. Questo perché gli standard iki non poterono fare a meno di evolversi, cambiando costantemente le proprie tendenze, ma quasi mai i principi. Col tempo, l’estetica iki divenne una fusione fra la sensibilità dell’ukiyo e il gusto urbano delle classi medie e ricoprì un ruolo centrale nell’elaborazione del gusto chōnin 町人. La parola si riferisce in primo luogo alla dinamica cultura urbana nata nel diciottesimo secolo nelle principali città del Giappone Edo e significa letteralmente “persone di città” o, più semplicemente, “cittadini”. Chōnin però fa riferimento anche a quel fenomeno culturale che diede vita a delle innovative tendenze di moda. L’ascesa della classe chōnin venne innescata principalmente dal drastico impoverimento della casta guerriera che già da tempo stava subendo delle pesanti perdite causate dalla legge del sankinkōtai 参勤交代. Tale sistema prevedeva che i daimyō 大名 abbandonassero periodicamente le loro terre per passare un determinato periodo di tempo nella capitale con le loro famiglie. Come se non bastasse, quando i signori facevano ritorno ai loro possedimenti, erano comunque obbligati a lasciare le loro mogli ed eredi a Edo come ostaggi dello Shōgun. Questa legge era stata imposta dallo shōgunato Tokugawa per controllare in prima persona tutti i daimyō del Paese, ma aveva anche lo scopo di far spendere loro quanto più denaro possibile. Le regolari spese di viaggio e il costo di una doppia residenza erano infatti così onerose da far abbandonare ai daimyō l’idea di affrontare i costi di una possibile guerra. Il declino della casta dei bushi portò così a una rapida ascesa della classe mercantile, i rigidi confini fra i ceti iniziarono a farsi più labili e una nuova realtà urbana con un forte senso per la moda iniziò a prosperare nei centri urbani. La priorità del mercato divenne quindi quella di soddisfare la domanda delle classi medie piuttosto che di quelle più alte.

Il desiderio dei cittadini per il capo più in voga del momento, portò i commercianti a creare degli speciali cataloghi noti come hinagata 雛形o hinagatabon 雛形本, grazie ai quali i clienti potevano scegliere fra una immensità di motivi con cui decorare abiti e accessori e anche con quali tessuti e colori realizzarli. Gli hinagata furono cruciali nel rafforzare l’economia della classe mercantile e, di conseguenza, la loro nuova posizione sociale. Inoltre, la comparsa degli hinagatabon aumentò notevolmente l’importanza dell’obi. Fino a quel momento, infatti, l’obi era poco più di una semplice cinta il per sorreggere i vari strati dell’ outfit, ma grazie agli hinagatabon divenne un indumento indispensabile quanto il kosode stesso, arrivando addirittura a eguagliarne il costo.

Con l’espansione della moda di massa, iniziò a farsi strada anche una nuova categoria di negozi di abbigliamento; il cui caso più iconico è sicuramente quello di Echigoya 越後屋. Fondato nel 1673, Echigoya iniziò la propria attività con il tipico commercio “porta a porta”. In meno di dieci anni l’impresa mutò in un negozio fisso dove poter comprare ogni tipo di prodotto. Il cliente tipico di Echigoya poteva essere sia un gran signore della classe più nobile che la figlia di un più modesto mercante, in quanto l’attività si relazionava con ogni classe sociale. Dopo Echigoya, furono molte le attività commerciali a seguire lo stesso modello di vendita; per di più, grazie alla politica del prezzo fisso delle compagnie, anche i cittadini comuni potevano ora permettersi un elegante kosode in seta o un elaborato obi dorato. E mentre gli abiti del ceto medio diventavano sempre più ricchi e sgargianti, quelli dei ceti più alti diventavano al contrario più sobri e modesti. Questo perché la gran parte del patrimonio delle classi guerriere più alte veniva investito in viaggi e immobili e la moda non rappresentò più una priorità. Perciò, il loro abbigliamento passò dai più brillanti rossi e ori a più morigerate nuances di blu, grigio e marrone, diventando una sorta di uniforme da lavoro.
Furono invece le donne a diventare le nuove leader del cambiamento nella moda, a prescindere dalla loro posizione sociale, in particolare quelle del Mondo Fluttuante Ciò che fu davvero strabiliante, è che questi ultimi erano perfettamente a conoscenza di quanto la loro influenza fosse potente. Durante la loro performance, infatti, gli attori Kabuki e le geisha indossavano spesso abiti con motivi e decorazioni che loro stessi creavano con il preciso intento di finire fra le pagine degli hinagata. Il giorno dopo l’esibizione, decine di donne erano già in fila davanti al loro negozio preferito per comprare lo stesso kosode che i loro beniamini avevano insossato la sera prima. Nonostante non vi sia nessuna certezza storica, pare inoltre che molte nobildonne tenessero delle gare di moda nelle loro residenze a Edo per eleggere il miglior outfit fra gli invitati. In realtà, il Mondo Fluttuante ebbe un notevole impatto nella moda di entrambi i generi, questo perché i quartieri a luci rosse di Edo, Kyōto e Ōsaka erano stati il primo luogo dove le persone potevano spogliarsi delle loro uniformi sociali una volta varcato l’ingresso del distretto, senza ripercussione alcuna. Lo shōgunato stesso scelse di non includerli nelle leggi, in quanto convinto che se i suoi sudditi avessero avuto un posto dove essere occasionalmente liberi, avrebbero obbedito più di buon grado nella vita di tutti i giorni.

La moda di massa nel Giappone Edo fu la prova che la passione per la novità nell’ambito dell’abbigliamento non avvenne solo in Europa. Di fatto, quando questa entrò in contatto con il Giappone a metà del diciannovesimo secolo, dovette inevitabilmente scontrarsi con una cultura il cui senso per la moda era stata un pilastro per più di due secoli e mezzo.
You May Also Like

Dipingere l’Ovest, lo stile Yokohamae.
23 Febbraio 2022
La religione proibita, la storia dei Kakure Kirishitan.
23 Febbraio 2022