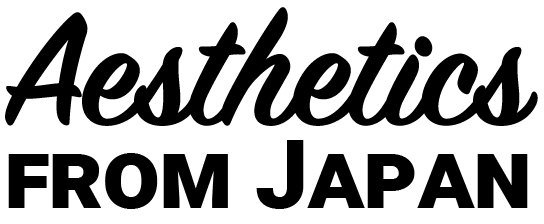Giappone in passerella: la moda giapponese dagli anni ’50 agli anni ’80
Fino agli anni ’50, il Giappone ebbe sempre un ruolo “passivo” nell’industria della moda. Nel momento in cui il Paese si aprì al resto del mondo, la sua cultura divenne la perfetta fonte d’ispirazione per i couturiers francesi. Perciò, per quanto il Giappone fosse sempre stato presente nel suo sistema, veniva sempre filtrato attraverso gli occhi degli stilisti occidentali. Le cose iniziarono a cambiare dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, quando la moda cessò di essere un’esclusiva francese e si trasformò in un mercato internazionale che riuscì a inglobare anche il Giappone stesso al suo interno. Il Paese, intanto, stava vivendo la sua personale rivoluzione di moda. Il vento del cambiamento iniziò a soffiare durante gli anni dell’Occupazione statunitense. Subito dopo la fine della guerra, l’abbigliamento occidentale in Giappone era ancora vittima dell’ infamia guadagnata durante quegli anni, soprattutto quello femminile; il motivo risiedeva principalmente nella campagna nazionalista e nelle propagande anti-occidentali che promuovevano un’estetica incentrata soprattutto sulla rappresentazione di una donna sottomessa e devota alla nazione. Solo agli uomini era concesso di usare vestiti in stile occidentale, mentre alle donne veniva richiesto di utilizzare principalmente kimono dai colori sommessi e rinunciare al makeup. Le donne in abiti occidentali venivano considerate erotiche e provocanti. Negli anni dell’Occupazione, infatti, solo le prostitute che avevano i soldati dello SCAP come clienti si vestivano in abiti occidentali. Sia le prostitute “autorizzate” che le panpan girls, le prostitute non ufficiali, si vestivano così nella speranza di attirare i loro clienti e aumentarne il numero. Nonostante fosse il governo giapponese stesso a incoraggiare le sue comfort women a usare questo tipo di abbigliamento, venivano tollerate a malapena dalla società. Tuttavia, quando le mogli e le figlie dei soldati arrivarono in Giappone, la brutta reputazione degli abiti occidentali sperì insieme a tutti i pregiudizi.

Dopo sette anni di occupazione, gli usi e costumi degli Stati Uniti si diffusero in tutto il territorio e il Giappone non potè fare altro che adottarli nella propria cultura, anche dopo che le truppe dello SCAP abbandonarono la nazione. L’industria del cinema, in particolare, ebbe un ruolo significante nella creazione delle nuove mode fra le generazioni più giovani. Fra tutti gli attori di Hollywood, la generazione post-guerra vide in Audrey Hepburn il vero e proprio simbolo della nuova bellezza giapponese. I suoi tratti delicati e il suo aspetto da “ragazza della porta accanto” erano qualità molto apprezzate dalla sensibilità giapponese; inoltre, la sua fama mondiale e le sue origini statunitensi erano delle caratteristiche abbastanza “insolite” per farla diventare un’icona del dopoguerra giapponese. Atttraverso il cinema, il Giappone potè avvicinarsi di più anche alla moda europea e, in breve tempo, le mode euro-americane divennero il principale punto di riferimento per stabilire i nuovi trend loali. Come risultato, l’abbigliamento occidentale sostiuì definitivamente quello tradizionale nella vita di tutti i giorni. La moda parigina era, ovviamente, il massimo dell’ispirazione a cui attingere. Gli abiti stretti in vita con ampie gonne proposti dal New Look di Dior, per esempio, divennero la moda più diffusa in Giappone sia negli anni ’50 che ’60. Ciò nonostante, quando il Giappone fece il suo ingresso nello scenario internazionale della moda, Parigi aveva smesso di essere l’unica capitale mondiale della moda già da tempo. Subito dopo la guerra, infatti, altre nazioni espansero il proprio mercato all’interno di questo settore e riusirono ben presto a eguagliare la popolarità della Francia. I nuovi movimenti giovanili degli anni ’60 come quello della Swinging London nel Regno Unito e quello degli Hippies negli Stati Uniti posero le basi per l’innovativo sistema del Prêt-à-Porter, minando l’incontrastato dominio della Haute Couture. Di conseguenza, Parigi passò dall’essere l’unica capitale della moda a diventare capitale simbolica della moda. La posizione di Tōkyō, d’altro canto, era quella di una città che aveva sviluppato una profonda sensibilità per la moda, ma era ancora ben lontana dall’essere una capitale della moda. È per questo motivo che la prima generazione di stilisti giapponesi decise piuttosto di stabilire la propria attività all’estero; nella loro visione, lasciare il Giappone era quantomai fondamentale per raggiungere quella fama mondiale a cui tanto ambivano.

Se si dovesse seguire un ordine cronologico, la prima stilista giapponese che raggiunse un riconoscimento in tutto il mondo fu Hanae Mori 森英恵 (1926-2022). A oggi, è l’unica stilista giapponese (e asiatica) a essere stata ammessa all’esclusiva Féderation Française de la Couture, nonché l’unica a ottenere lo status di couturière. Hanae inizia la sua carriera nel mondo della moda subito dopo il suo matrimonio con l’imprenditore tessile Mori Ken森賢nel 1946. Sei anni dopo, inaugura il suo primo atelier e iniza a lavorare anche nell’industrie del cinema. Nel 1961, viaggia a Parigi per imparare di più sulla Haute Couture e fa la conoscenza di Coco Chanel, diventando la sua prima cliente giapponese. Nello stesso anno, ha la possibilità di assistere a una rappresentazione della Madama Butterfly a New York e durante quell’evento capisce quanto distorta e limitata fosse la concezione di abbigliamento giapponese all’estero. In fin dei conti, in quel periodo il Giappone stava ancora facendo i conti con l’immaginario fittizio creato dalla corrente orientalista un secolo addietro e veniva ancora immaginato come un Paese di geisha e “samurai” ricco di spiritualità dove la tradizione aveva la meglio sul contemporaneo. Perciò, quando Hanae Mori lanciò la sua prima collezione a New York “East meets West”, ebbe un grande riscontro da parte della stampa e della critica: da una parte, la sua moda viene percepita come “autenticamente” giapponese, in quanto Hanae stessa era una stilista giapponese, come dimostrato dall’uso di sete, motivi floreali e geometrici tradizionali e maniche in stile furisode nelle sue collezioni. D’altra parte, tuttavia, le sue creazioni erano ben lontane dall’essere una mera copia degli abiti tradizionali giapponesi: i kaftani dai colori brillanti e gli ampi vestiti delle sue sfilate dimostrano come Hanae fosse anche ben consapevole di quali fossero i trend del momento. Grazie al suo successo internazionale, Hanae diventa anche la stilista ufficiale per il personale di bordo della Japan Airlines, la compagnia aerea ufficiale del Giappone. Negli anni ’70, si trasferisce definitivamente a Parigi da New York, dove inizia a lavorare anche come stilista prêt-à-porter; sia in questo settore che nella Haute Couture il suo concetto di moda è pensato per una donna eterea ed elegante, capace di andare oltre la rigidità del corpo. Durante tutta la sua carriera, Hanae non smette di realizzare costumi per il cinema e il teatro e nel 1985, ironicamente, è anche la costumista per la Madama Butterfly della Scala a Milano. Dato il suo profondo legame con questa opera, la farfalla diventa il simbolo del suo brand. Inoltre, stando alle parole di Hanae Mori stessa, la farfalla incarnava perfettamente l’essenza stessa del suo marchio: una creatura delicata e raffinata che con la sua grazia riesce a incantare chiunque la guardi.

Hanae Mori è stata indubbiamente la prima a scatenare molti ripensamenti sull’abbigliamento giapponese nel campo della moda; nonostante ciò è molto spesso considerata come una stilista giapponese unica nel suo genere, in quanto la storia del suo brand presenta delle unicità che non si possono trovare negli altri stilisti dopo di lei. In primo luogo, Hanae era è abbastanza ricca per poter inizare a lavorare come couturière, senza passare prima dall’industria del ready-to-wear, ma ciò che fa davvero la differenza tra lei e i suoi colleghi è che Hanae Mori non cercò mai di dare quell’effetto “avant-garde” nelle sue collezioni. La sua moda riadattò l’abbigliamento tradizionale giapponese ai canoni occidentali, eppure il modo in cui lo fece era tutt’altro che una provocazione per il pubblico; Hanae Mori scelse piuttosto di perseguire dei canoni già esistenti, abbandonando completamente l’idea di ridefinire le estetiche della sua cultura. È per questo che la scena della moda mainstream riconosce in Takada Kenzō 高田賢三(1939-2020), semplicemente conosciuto come Kenzo, il vero pioniere della moda giapponese nel mondo.

L’attrazione per il mondo della moda fin dall’infanzia porta Kenzo a diventare uno dei primi allievi maschi del Bunka Fashion College di Tōkyō. Si trasferisce a Parigi quasi per caso, quando nel 1964 il governo gli diede un rimborso dopo la demolizione del palazzo dove abitava. Inizialmente, vende i suoi bozzetti e modelli ad altre case di moda a prezzi irrisori, faticando per potersi permettere un tenore di vita decoroso. Nel 1970, riesce a prendere in affitto per una modica cifra un piccolo spazio alla Galerie Vivienne e gli da il nome “Jungle Jap”; l’ispirazione per il concept dello store arriva dall’opera “the Dream” del pittore Henri Rousseau e natura, fiori e alberi ne sono il tema centrale. Quando a Kenzo viene richiesto di presentare la sua prima collezione, il suo budget è ancora molto limitato; decide perciò di acquistare semplicemente alcuni scampoli di stoffe varie al mercatino delle pulci. Il risultato in passerella è strabiliante: attraverso la fusione fra tessuti tipici giapponesi e stampe etniche, Kenzo riesce a creare a un’estetica mix-and-match mai vista prima e la stampa non può che accogliere positivamente le sue collezioni, tanto da vedere in lui il precursore della nuova scena internazionale della moda. Altra novità della sua prima collezione sono gli outfit larghi e tendenti all’oversize; Kenzo stesso, in realtà, non è mai stato amante dell’abbigliamento aderente proposto dalle mode parigine. In ogni caso, questa scelta è anche in parte dettata dalla sua cultura d’origine, in quanto il sistema di abbigliamento giapponese ha sempre preferito la larghezza rispetto all’aderenza. In aggiunta, il suo brand propone anche l’uso di meteriali più modesti quali il cotone e la lana per poter dare vita ad ampi abiti dalle ispirazioni vittoriane che a malapena mostrano le forme naturali del corpo. Nelle collezioni di Kenzo, colorati tessuti floreali e stampe camouflage vengono spesso abbinati a capi realizzati con scampoli di yukata e kimono, estetica che diventerà anche un importante punto di riferimento per il celebre Flower Power look, all’epoca di grande tendenza. Nonostante abbia sempre insistito per essere identificato semplicemente come “stilista” piuttosto che “stilista giapponese”, durante tutta la sua carriera Kenzo non ha mai esitato a servirsi delle sue origini giapponesi, seppure lo abbia fatto in maniera decisamente singolare; egli ha difatti distrutto i canoni dell’estetica tradizionale per ricombinarli in uno stile di moda unico, dimostrando quanto la tradizione giapponese non fosse sinonimo di staticità e provandoquanto potesse adattarsi ai moderni standard occidentali di quegli anni. È per questo che Kenzo viene spesso considerato come il primo stilista giapponese che diede davvero un valore internazionale alla scena della moda giapponese.

Il successo mondiale di Kenzo lo fece diventare una celebrità anche nel suo Paese natale e molti stilisti suoi connazionali lo presero come modello, decidendo di proseguire la loro carriera fuori dal Giappone. Fra loro, tre in particolare riuscirono a fare la storia con la loro idea di moda: Issey Miyake 三宅一生 (1938-2022) Rei Kawakubo 川久保玲 (1942) e Yohji Yamamoto山本耀司(1943) meglio noti con l’espressione inglese “The Big Three” (i Tre Grandi della moda giapponese) per via delle grandi innovazioni che portarono con le loro collezioni ready-to-wear. La loro estetica di moda ha dato nascita a un nuovo trend che viene spesso definito “avant-garde giapponese” e i tre hanno indubbiamente molti punti in comune: per prima cosa tutti e tre ridefiniscono dalle basi i canoni dell’intero sistema sartoriale con l’introduzione di nuove tecniche di confezionamento dell’abito e offrendo la possibilità di indossare un indumento in diversi modi. I loro outfit erano quindi agli antipodi di tutto quello che Parigi era abituata vedere: in passerella, i loro abiti appaiono incompletie asimentrici, avvolgendo il corpo dei modelli in maniera tale da far sparire del tutto le forme dei loro corpi. L’effetto finale è quello di un look essenziale e monocromatico in cui il corpo umano sparisce quasi completamente. Così come aveva fatto Kenzo, con la loro moda i Big Three distruggono i canoni dell’estetica giapponese tradizionale per poi ricostruirla da zero, ma il modo in cui lo fanno è di gran lunga più estremo di quello di Kenzo. Il rifiuto esplicito per il concetto di bellezza creato dalla moda parigina porta questi tre stilisti a crearne uno del tutto nuovo che va oltre le taglie e le forme del corpo. Questa scelta, inizialmente, scatena il dubbio da parte della critica che però non potè infine fare a meno di innamorarsi delle loro collezioni oltraggiose per via dell’originalità che queste portarono nell’industria della moda. Un’altra peculiarità dei loro outfit era la mancanza della distinzione di genere, rendendoli quindi indossabili da chiunque. Sempre sulla scia di Kenzo, anche i Big Three non amavano farsi chiamare “stilisti giapponesi”; tuttavia è impossibile negare che, anche nel loro caso, la moda tradizionale giapponese, il kimono in particolare, sia stato di fondamentale importanza nella loro moda. In ogni caso, per quanti punti in comune i Big Three avessero, ognuno di loro presenta anche una propria identità a livello stilistico che rende impossibile non riconoscere le loro creazioni in passerella.

Nel 1976, Issey Miyake lancia“A Piece of Cloth”, una collezione dove l’intero outfit viene realizzato da un unico pezzo di stoffa che avvolge interamente il corpo. Più che su una ricerca estetica, quella di Miyake punta a mostrare le relazioni inesplorate fra il corpo e il tessuto che lo ricopre, creando così nuovi spazi fra i due elementi. La collezione ottenne talmente tanto successo che ne viene riproposta una reinterpretazione nel 1999, stavolta con il nome di “A-POC”: in questa versione Miyake utilizza un lunghissimo pezzo di jersey per realizzare tutti i capi che andranno a comporre un outfit monocromatico. L’intero processo di confezionamento è gestito da un computer per evitare inutili sprechi di stoffa. Negli anni ’90, Miyake da vita a “Pleats Please”, una delle sue collezioni più celebri, alterando drasticamente il processo di confezionamento del plissé: invece di plissettare la stoffa prima di essere tagliata, Miyake decide di realizzare le plissettature sull’indumento preconfezionato. Il risultato finale è un insieme di plissé multi-strato che vanno in diverse direzioni senza seguire un senso preciso, rimodellando così le forme del corpo. I capi Pleats Please sono anche molto pratici, in quanto possono essere lavati in lavatrice senza perdere le pieghe e non hanno bisogno di essere stirati. Il brand propone nuove collezioni Pleats Please ogni anno e molto spesso gli artisti più famosi collaborano alla loro realizzazione offrendosi di dipingere le loro opere sulla stoffa prima che venga plissettata. Nello stesso periodo di Pleats Please, Miyake presenta anche la collezione “Tattoo Body”, fortemente in contrasto con i suoi principi estetici: in questa collezione, infatti, delle tute stampate in poliestere aderiscono al corpo come una seconda pelle, mostrandone ogni curva. Lo scopo era, ovviamente, quello di rappresentare un finto corpo nudo completamente tatuato.

Rei Kawakubo crea il suo marchio di moda “Comme des Garçons” nel 1969 e da allora ha sempre prodotto questa etichetta; tuttavia il marchio non viene creato a Parigi ma a Tōkyō. Il suo concetto di moda viene ancora considerato come il più avanguardistico fra i tre stilisti e, a differenza di questi ultimi, Rei non affrontò mai il percorso di studi canonico per uno stilista di moda. Questa sua “mancanza” la porta così a produrre delle collezioni che vanno ogni standard di tutto il sistema sartoriale e le sue sfilate sfidano qualsiasi convenzione estetica della moda di quegli anni. Nel 1981, la sua collezione “Hiroshima chic” lascia la stampa senza parole: gli enormi indumenti strappati indossati dalle modelle in passerella appaiono incompleti, rovinati e quasi realizzati a metà, come se queste fossero sopravvissute a un’apocalisse nucleare. Giacche oversize e maxi dress nascondono i loro corpi, mentre delle giganti gonne in crinolina e enormi pantaloni sfidano rimettono in duscussione i canoni della geometria. In generale, l’ideale di bellezza proposto da Comme des Garçons non ha come obiettivo quello di esaltare il corpo e si libera quindi di tutte le restrizioni di genere imposte dalla società. Sempre negli anni ’80, Rei Kawakubo realizza numerose collezioni monocromatiche sui toni del nero, del grigio e del bianco che prevedono anche un ampio uso di accessori realizzati in pelle e acciaio. Il suo brand diventa così uno dei punti di riferimento per lo stile gotico e la Dark Wave di quegli anni. Negli anni ’90, invece, propone una collezione realizzata quasi interamente con abiti in carta, riproponendo un’usanza dell’antico Giappone. Col tempo, Comme des Garçons sperimenta anche l’uso dei colori nelle sue collezioni, senza però mai abbandonare il suo gusto “anti-moda”.


Nei tardi anni ’70, Yohji Yamamoto fa coppia nel lavoro e nella vita con Rei Kawakubo e la loro relazione influenzerà inevitabilmente il loro lavoro. Yohji debutta per la prima volta in passerella a Tōkyō nel 1977 e nel 1981 le sue collezioni sfilano anche a Parigi sotto il brand “Y’s”, che corrisponde oggi alla sua linea low-price. Così come Rei Kawakubo, il suo obiettivo iniziale è quello di offrire alle donne un diverso tipo di bellezza; pertanto la sua prima collezione si basa anch’essa su un’estetica post-apocalittica ottenuta tramite la creazione di indumenti strappati e privi di forma. Nelle sue sfilate, i modelli in passerella indossano capi oversize multi-strato e non c’è mai la separazione tra collezione uomo e collezione donna. Inoltre, Yamamoto adora abbinare capi di lusso a capi modesti. Sia Yohji Yamamoto che Rei Kawakubo danno vita a quello che è ancora conosciuto come Boro Look, parola giapponese per dire “mendicante”. Nel 1995, Yamamoto propone una collezione con capi realizzati tramite la tecnica shibori, il tie-dye tradizionale giapponese. Tuttavia, il vero protagonista indiscusso del suo brand è il colore nero e anche quando un outfit presenta altri colori, lo scopo è quello di enfatizzare il nero stesso. Il risultato è un look gotico e misterioso che rappresenta ancora oggi il punto focale dell’idea stessa di moda di Yamamoto. Anche lui diventa così uno degli stilisti di riferimento della Dark Wave degli anni ’80. Nel corso degli anni, il suo marchio ingloba anche elementi estetici delle mode occidentali: gradualmente, indumenti più attillati al corpo compaiono accanto ai soliti capi oversize e tessuti quali pizzo e tulle si abbinano sempre di più a jersey e cotone. L’estetica gotico-vittoriana, in particolare, diventerà un altro simbolo della moda di Yamamoto insieme al nero.

A partire dalla fine degli anni ’90 circa, sempre più stilisti giapponesi si unirono alla scena mainstream della moda ed essere giapponese in questo ambito non rappresentò più una novità; il resto del mondo si rese conto che anche il Giappone era in grado di produrre moda di qualità e Tōkyō passò dall’essere una città con un gran senso della moda all’essere una capitale della moda vera e propria come Parigi, Londra, Milano e New York. Attualmente, la capitale giapponese ospita numerose fashion week da più di quindici anni ed è considerata come l’apoteosi della street fashion. Tanti stilisti e lavoratori del settore vengono ogni anno da tutto il mondo a Tōkyō in cerca di stimoli e idee per il loro lavoro, proprio come la prima generazione di stilisti giapponesi aveva fatto più di mezzo secolo fa.
You May Also Like

Semplice è chic, la moda nel periodo Edo
23 Febbraio 2022
Speranza, futuro e nostalgia: storia della Torre di Tokyo
11 Aprile 2022